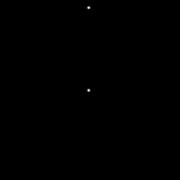Un altro fenomeno di violenza: l’esperienza con le vittime della tratta
Dal 2007 al 2012 ho condotto un gruppo per donne che vittime della tratta costrette alla prostituzione. Queste donne avevano subìto traumi catastrofiche estreme e prolungate. Erano state portate in Italia e poi vendute agli sfruttatori. Il loro documenti erano stati confiscati. Non conoscevano l’italiano. Alcuni di loro non sapevano nemmeno in che paese fossero. Non avevano nessuno idea dove andare per chiedere aiuto. Erano schiave.
Inoltre quando ‘lavoravano’, vivevano nel terrore: quando salivano in macchina con un cliente non potevano sapere se il cliente fosse violento o no. Per esempio R, una donna nigeriana, (userò solo l’iniziale dei nomi) è stata accoltellata 40 volte e lasciata per morta in mezzo alla strada.
I papponi imponevano un rapporto di dominio assoluto sulle ‘loro’ donne. Lo facevano attraverso botte, torture e stupri. Per esempio una delle donne, I. ha detto: “sapevi che se non guadagnavi abbastanza, quando tornavi a casa ti aspettava la bacinella d’acqua e gli elettrodi.” Quasi nessuna della donne sapevano cosa le aspettava una volta arrivata in Italia. Darò qualche esempio. Dopo che il marito aveva abbandonato lei e i tre figli, L., una donna peruviana, ha ricevuto una lettera dallo zio che si era trasferito in Italia. Ha promesso un lavoro in un ristorante alla nipote dove lei avrebbe guadagnato abbastanza da mandare soldi a casa per i figli. Quando L. è arrivata in Italia,lo zio e i suoi amici le hanno sequestrata e stuprata a turno per ‘addestrarla’. Poi è stata messa su strada. L. era incinta di tre mesi, ed è stata costretta a ‘lavorare’ fino al giorno prima del parto e a riprendere il giorno dopo. Un’altra donna, una serba, era stata venduta da suo padre agli zingari per €2000 quando aveva 12 anni. E’ stata prima stuprata dal gruppo che le aveva comprato e poi portata in Italia, dove è diventata madre all’età di 14 anni. M., una donna rumena, è stata agganciata in Romania da un uomo che le ha promesso che la tubercolosi da cui era affetta poteva essere curata in Italia. Quando M. è arrivata lui le ha sequestrata, violentata e la torturata. Poi le ha messa su strada.
Forse la storia più significativa per rappresentare lo svolgimento della tratta dall’Africa sub Sahariana è quella di R., una donna nigeriana.. A Lagos un uomo che sembrava averle preso sotto le sue ali protettive ha offerto di prestarle i soldi per il viaggio in Italia. Insieme ad altre donne, R. ha fatto il tratto tra la Nigeria e il Niger a piedi dove poi un camion le ha raccolte e portate a un villaggio. Sono state confinate in una piccola stanza e costrette alla prostituzione; potevano uscire solo per incontrare i clienti. Diversi mesi dopo le donne sono state trasferite in un camion e hanno attraversato il deserto. Il camion era strapieno e alcune delle donne erano costrette a fare il viaggio aggrappandosi alle sbarre di ferro che reggevano la copertura del camion. Se si addormentavano e cadevano il camion non si fermava per raccoglierle ed erano lasciate nel deserto a morire. Dopo soste in varie cittadine dove di nuovo erano costrette al prostituirsi, sono arrivate a Tripoli dove di nuovo erano sequestrate e costrette alla prostituzione.. A Tripoli R. è stata marcata con un ferro rovente in modo che una volta arrivata in Italia poteva essere identificata dallo sfruttatore a cui era stata venduta. Ha fatto il viaggio in Italia su un gommone ed è stata uno dei pochi che è stata salvata dalla Guardia Costiera italiana dopo che il gommone si è rovesciata. Dal momento della partenza dalla Nigeria fino all’arrivo in Sicilia sono passati due anni. Questa è la storia di R. ma è anche la storia delle donne africane che arrivano in Italia oggi.
Il dilemma di chi lavora con le vittime di traumi catastrofici estreme e prolungate è stato posto da Sandor Ferenczi: “sono state così completamente schiacciate dallo shock che devono essere considerate irrecuperabili, più esattamente uccise del tutto”? (Il Diario Clinico, p. 131). Nel suo lavoro con pazienti traumatizzati, Ferenczi ha teorizzato che “l’unica forma di esistenza che [rimane è dopo l’effrazione traumatica è] l’atomizzazione completa della vita psichica” (Il Diario Clinico, p. 57), e che se l’effrazione non è contrastata può persino portare alla morte fisica. L’atomizzazione psichica crea zone di silenzio che non possono essere pensate e che rende la vittima estrania alla propria storia. Una delle donne del gruppo ha detto: “So cosa vuol dire essere ridotta in polvere”. Un’altra ha detto “Sono stata derubata della mia vita”. Altre hanno detto “Io sono scomparsa”. E tutte, in un modo o in un altro, hanno detto “Io non c’ero”. Un esempio è A, una donna albanese, che presentava tutti i segni dell’atomizzazione psichica quando ha iniziato a frequentare il gruppo. Era quasi totalmente incoerente; saltava da un pensiero all’altro senza soluzione di continuità e una volta che iniziava a parlare non riusciva a fermarsi. Il suo pappone, un connazionale, era estremamente sadico. Amava circondarsi di coltelli che spesso usava per tagliare A, che si è trattenuta con lui perché ha minacciato di uccidere la sorella rimasta in Albania se A. scappava. Un giorno, quando il pappone per l’ennesima volta ha minacciato di ucciderla, A. ha percepito che questa volta lo avrebbe fatto davvero. Ed è fuggita. Dopo qualche tempo il pappone si è trasferito sull’Adriatico dove usava ragazzi minorenni per distribuire le droghe in cui trafficava. Un giorno uno dei ragazzi lo ha ammazzato, e quando A. ha saputo che era morto e che non poteva più minacciarla, ha cambiato il giorno della sua data di nascita su Facebook. Gradualmente ha recuperato la capacità di parlare in modo coerente. Quando, a distanza di qualche anno, io e un’operatrice del Centro abbiamo capito che A. aveva un interesse vero per lo studio, le abbiamo appoggiata mentre con grande determinazione è riuscita a fare passi burocratici necessari per far riconoscere in Italia la maturità albanese. Si è iscritta alla Sapienza e sta per laurearsi.
Il lavoro del gruppo. Nonostante la consapevolezza che sia io che le donne avremo lavorate vicino al terrore, ho accettato di lavorare con loro perché speravo che poteva essere utile. Anzi sapevo che i gruppo sono molto potenti: sono composti da individui, ma non sono la mera somma dei singoli. Esercitano infatti un’influenza magnetica (Freud), esprimono una volontà e creano una mentalità gruppale (Bion). Inoltre i gruppi attingono alla psiche dei loro membri, generando un apparato psichico gruppale che costituisce il luogo della realtà specifica del gruppo, al quale gli appartenenti subordinano la loro realtà individuale (Kaes). Per dirlo in altre parole, i gruppi assumono una vita proprio, sia sul livello interpsichico che intrapsichico.
La mia ipotesi era che il gruppo poteva attivare nelle donne la fantasia che le loro esperienze traumatiche potevano essere rappresentate sul ‘palcoscenico’ del gruppo e che la psiche gruppale poteva gestirla e trasformarla. In altre parole, speravo che la loro angoscia poteva trovare un contenitore nel gruppo. Inoltre il gruppo (insieme alla casa rifugio dove vivevano) poteva potenzialmente attivare ciò che Kaes ha chiamato gli organizzatori social-culturali inconsci che sarebbero state alternative a quelle con cui le donne si sono identificati: all’inizio del gruppo, si consideravano puttane.
Il gruppo si riuniva ogni due settimane alla Casa Internazionale delle Donne. I membri provenivano da varie paesi – Brasile, Kenya, Nigeria, Romania, Serbia, Perù, Ucraina. Io sono americana. Ovviamente non avevamo una lingua comune: comunicavamo in Italiano e attraverso gesti e passaggi di emozione. Prima di iniziare il gruppo le donne avevano raccontato le loro esperienze sia alle operatrici dei centri che alla polizia: la legge italiana impone il rapporto con la polizia perché così può essere rintracciato lo sfruttatore e la rete criminale di cui fa parte. Questa ricostruzione delle loro storie era una necessità burocratica, ma credo che il sistema legale e le leggi che lo governa servissero a introdurre un terzo elemento psichico che non era dominato dal rapporto totalitario con il pappone onnipotente e che questo ha aperto la possibilità per la creazione di uno spazio psichico nuovo che rendeva immaginabile l’inizio della differenziazione e la creazione della soggettività, il pensiero e la parola individuale.
Ci vedevamo ogni due settimane nella stessa ora e nello stesso luogo. La costanza del setting aiutava loro a distinguere interno ed esterno, distinzione che nel trauma non esiste più. Nel tempo i membri del gruppo incominciavano a riconoscere che erano state (nelle parole di Emily Dickinson) vicini al tremendo. Questa consapevolezza agiva come antidoto alla confusione comune alle vittime di traumi prolungate: la fiducia nella testimonianza dei propri sensi è distrutta e la persona non si riconosce più. Le donne esprimevano il sollievo offerto dalla partecipazione del gruppo dicendo che lì erano sicure che le loro storie sarebbero state credute. La capacità di trovare parole che rappresentavano le loro esperienze costituiva il primo passo verso la ricostruzione del loro Se.
Gradualmente, lo scenario del gruppo da “io sono una puttana” è diventata “io stato stata sfruttata dal mio pappone e dai miei clienti; sono stata tenuta contro la mia volontà; ero una schiava. Ma non sono più una schiava”. Incominciavano ad identificarsi come donne che avevano sofferte delle ingiustizie enorme. Per esempio, all’inizio del gruppo, A., una delle donne nigeriane, parlava di se stessa come una puttana. Grazie al centro rifugio ha trovato uno stage in un ristorante e quando un collega scherzosamente ha chiamato un’altra con l’appellativo “puttana”, A. è esplosa e lo ha attaccato fisicamente. Era diventato intollerabile usare la parola puttana con leggerezza: adesso A. identificava la parole con la sofferenza e il dolore. Narrando gli episodi di violenza e costrizione a cui erano state obbligate dal pappone, gradualmente riuscivano ad identificarle come aberrazioni, come ingiustizie che non dovrebbero esistere. Vedevano le loro esperienze come così aberranti che si chiedevano come fosse stata possibile che i papponi le avevano sottoposte a condizioni così estreme. Un giorno A., la donna nigeriana, ha parlato per tutte, dicendo “Come avrebbero potuto succedere queste cose? Come? Come? Come è possibile che esistono persone senza cuore?”. In altre parole si sono potute riconoscere come donne che avevano subito esperienze terribili e ne erano sopravvissute.
Ferenczi ha teorizzato che “dev’essere offerto qualcosa che sia un contro peso alla loro sofferenza” ai pazienti molto traumatizzati. Penso che l’associazione contro la violenza e il centro, che facevano parte di una rete italiana ed internazionale, offrivano delle possibilità per nuove identificazioni: il nostro piccolo gruppo era parte di un gruppo più grande (l’associazione) in rete con associazioni nate per trasformare la percezione sociale e culturale delle violenza e della risposta collettiva ad essa in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Questo ha voluto dire che il gruppo è abbastanza potente da poter offrire un’alternativa al terrore del pappone ‘onnipotente’. Inoltre il movimento contro la violenza alle donne ha degli ideali e dei valori con cui le donne potevano identificarsi e che sono sancite dalla Convenzione di Istanbul delle Nazioni Unite e da una Risoluzione del Parlamento Europeo.