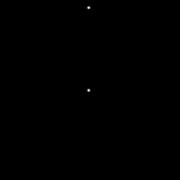Dalla narrazione ai dati: riconoscere e affrontare la violenza contro le donne
Questo intervento mi riporta alla mia esperienza individuale, nel senso che il discorso tratterà anche la personale declinazione di cosa significa essere una ricercatrice, una studiosa oggi; cosa vuol dire in questo momento occuparsi di violenza contro le donne. In parte molte cose le ha già dette Valeria Babini, noi condividiamo un’esperienza felice: il ciclo di seminari curricolari dell’Università di Bologna e il successivo libro Lasciatele vivere, quello è stato un momento altamente politico e io penso che il contributo che una studiosa, una persona che si occupa di questi temi, abbia il pieno senso dell’impegno politico. Ci tengo a sottolineare come una ricercatrice sociale debba in qualche modo entrare nel merito del tema della violenza maschile contro le donne. Il mio intervento è legato ad un coinvolgimento diretto e personale, da una parte c’è un elemento importante ,ricordato da Oria Gargano: la condivisione dell’esperienza – insieme a Serena Dandini – del progetto Ferite a morte,un libro e un evento teatrale molto strettamente collegato alla mobilitazione dei centri di violenza, delle associazioni femminili e femministe per la ratifica della convenzione di Istanbul, che ancora in Italia non era stata effettuata. Dall’altra, la presenza di un elemento che mi piace ancora sottolineare: la relazione molto stretta che c’è – quando ci si occupa di violenza contro le donne – con il mondo delle associazioni. In questi ultimi 20 anni ho seguitato a lavorare in questo campo, cominciando proprio quando Anna Finocchiaro è stata nominata ministra delle pari opportunità, la prima in Italia, sull’onda della conferenza di Pechino, sempre interloquendo e collaborando con la politica. Ma soprattutto molto imparando: le cose fondamentali che mi sono servite nella ricerca sono state quelle di conoscere il lavoro dei centri antiviolenza, uno snodo cruciale anche a livello scientifico, di capire cosa succede veramente, e questo approccio permette di utilizzare la ricerca, lo studio, l’analisi nel mio caso dei dati, ma anche dei dati qualitativi oltre che quantitativi, consente di avere delle ipotesi di lavoro e di verificare e confrontarsi con un’esperienza estremamente originale del movimento femminista e di quello che si è costruito nel consolidamento dei centri anti violenza e della cultura dell’anti violenza in Italia. Molto è dovuto a una elaborazione anche metodologica di studio e dell’analisi, che poco a che vedere con la ricerca accademica, e che ha molto a che vedere con l’esperienza diretta di un approccio che si è continuamente evoluto. Questo chiaramente non significa considerare questa metodologia come l’unica possibile per affrontare la violenza, ma nel mio caso personale questo mi ha consentito di orientare e calibrare il mio tipo di ricerca e di lavoro nel tempo. Il mio settore di ricerca, io sono di formazione statistica, è cresciuto con me, possiamo dire: è partito decisamente quantitativo e poi progressivamente, ha sconfinato in altri campi non strettamente quantitativi. Tuttavia questa formazione mi ha consentito, mi consente, di fare delle cose -secondo me- abbastanza utili ‘tecnicamente’ alle politiche contro la violenza., nel senso di misurare, catturare le dimensioni del fenomeno e trovare le strategie per farlo. Per capirci , prima del 2007 quando sono usciti i primi dati ISTAT sulla violenza sulle donne, la prima indagine campionaria condotta in Italia, finanziata dal dipartimento delle pari opportunità, è stato uno shock collettivo, una doccia fredda collettiva, perché 6 milioni e 743 mila donne che almeno una volta nel corso della vita hanno subito violenza è qualcosa che, in una cultura che non crede alle donne, ha rappresentato un cambio di visione fondamentale, perché i numeri sono lì, li vedete, i numeri sono santificanti. Se lo dicono i numeri, sarà vero. È stata un’indagine di straordinaria importanza perché è stata la prima come detto, preparata in due anni, quindi molto complessa, un’indagine telefonica fatta da operatrici che hanno avuto una formazione specifica, perché la dimensione sommersa è un fenomeno che non si vede per definizione. Cioè è una cosa che non si vede, non parla, non esiste, quindi l’Istat ha cercato di andare al di là di quel miserrimo 12% di denunce del partner che noi abbiamo , perché se ci dovessimo basare solo sulle denunce avremmo solo una visione strabica del fenomeno. Ma quello che appare altrettanto importante attraverso queste indagini è che , andando a chiedere alle donne si restituisce la parola alle donne, anche attraverso un’indagine che le chiama a casa e domanda “signora cosa le è successo? Le è capitato di essere mai stata schiaffeggiata?”. Guardate che nelle domande dell’ISTAT, sono descritte delle cose orribili, pensate a una telefonata che arriva in una casa e una donna risponde raccontando la sua storia di violenza, e quasi mila 7 milioni di signore rispondono affermativamente. Ora, la seconda indagine del 2014 ha confermato la magnitudo di questo fenomeno, ma è una emersione di parole caratterizzata dalla vergogna, raramente sentiamo una donna che ha subito violenza che racconta la sua esperienza. Sappiamo perché, non aggiungo nulla…quindi è essenziale in questo caso, andare a scavare sotto quel pezzettino di dati e informazioni che vengono erogate. Ora ecco un altro discorso è la diffusione di queste informazioni e l’uso di quelle statistiche: ne abbiamo parlato, abbiamo avuto un giornalista questa mattina, questo è un grosso problema. La veicolazione dei messaggi riguardo la violenza hanno questo appiccicaticcio morboso che non permette mai di capire effettivamente cosa sta succedendo. L’incapacità di dire : 7 milioni di persone sono tante, per non parlare delle donne uccise , dei femminicidi. Mi ricollego a Ferite a morte, anche lì l’operazione che abbiamo fatto è stata quella di dare, restituire parola, vita e racconto a persone morte. Quelle non sono storie vere, ma sono ispirate a fatti di cronaca, abbiamo passato un’estate intera con gli incubi perché ci siamo lette i giornali, la cronaca nera italiana e non italiana, articoli che raccontavano di donne uccise dal loro partner, ma anche uccise da un molestatore, o altri casi di femminicidio, di tipo diverso. Questo discorso della restituzione, della definizione, è un discorso estremamente importante e delicato, perché è quello che individua il nostro linguaggio comune. Il linguaggio comune non esiste, o solo in alcune cerchie: per esempio parliamo di un elemento fondamentale della statistica e della descrizione ufficiale, ossia della restituzione di questo fenomeno dal punto di vista scientifico/qualitativo. Qui c’è un problema fondamentale: se da una parte il fenomeno della violenza sulle donne può essere raccontata solo da quel tipo di indagini che vanno a sondare il sommerso, dall’altra la violenza può essere intercettata e misurata anche attraverso la risposta che lo Stato dà alle persone che chiedono supporto: può essere andare in un centro anti violenza o al pronto soccorso, parlare con il proprio insegnante, fare una denuncia in procura, parlare con il proprio medico, con il proprio terapeuta o con il proprio avvocato o con un poliziotto. Questo è molto importante è un obbligo dello Stato- la convenzione di Istanbul introduce questo concetto del “dovere dello Stato di dare supporto, proteggere e punire le vittime di violenza”. Questo dovere si declina attraverso un sistema articolato molto complesso di servizi, dicevamo prima: dai dati dell’Istat viene fuori che sono circa il 4%le donne che si rivolgono ai centri specialistici anti violenza. Tutte le altre dove vanno? Ai consultori, ai servizi sociali, alla polizia? Quindi c’è il problema, lo dico non solo da statistica, di utilizzare questo enorme potenziale di informazioni che risiede in ogni organizzazione perché i poliziotti raccolgono le denunce, i pronto soccorsi fanno i referti, ecc… i servizi sociali hanno delle liste di persone che vanno…è una grande rete di servizi, ma nessuno di questi definisce la violenza e le tipologie di violenza nello stesso modo, e quindi si raccolgono informazioni utili solo alla valutazione interna, che non vengono messe in rete, non vengono armonizzate, non vengono confrontate, quindi noi non sappiamo, ci arrabbiamo ogni volta, mi riferisco al 25 Novembre, che chiediamo più soldi, ma non sappiamo, a parte per i centri di antiviolenza, che cosa succede dopo le azioni, per esempio il precedente piano anti violenza prevedeva la formazione. Ma chi è stato formato? E quanti? Quanti poliziotti? Quanti carabinieri ? quanti dottori? Sono informazioni che valgono una per una… quindi non siamo in grado di valutare qual è l’impatto corale dell’impegno dello Stato in risposta alla violenza maschile contro le donne.
La convenzione di Istanbul è qualcosa che farà cambiare il passo all’Italia e a tutti i Paesi che hanno aderito, ci obbliga a impegnarci come Stato ad adottare delle leggi che permettano l’applicazione dei principi degli articoli previsti dalla convenzione. Quindi è una dispositivo organizzato in cui ogni Stato si deve chiedere cosa possiamo fare per l’applicazione dell’articolo x?
All’articolo 11 la convenzione prevede la raccolta sistematica dei dati, una raccolta dati armonizzata che preveda sia i dati delle indagini, ma anche i dati che provengono da tutti quei servizi che hanno a che fare con le persone che possono aver subito violenza. E questo è molto importante, molto impegnativo, ma è un aspetto fondamentale. Perché per la prima volta in base al piano strategico contro la violenza maschile, nei prossimi tre anni, si lavorerà a che questo sistema arrivi a regime e finalmente potremo parlare con cognizione di causa. Potremo chiedere “Questo Stato è in grado di rispondere? È all’altezza della sfida?”
Anna Finocchiaro stamattina ha detto una parola “mainstreaming di genere” io dico “empowerment”, sono due principi identificati nel 1995 a Pechino e recepiti nella direttiva Prodi – Finocchiaro e nella convenzione di Istanbul. Sono concetti che non sono stati pienamente trasfusi nella politica, il mainstreaming di genere è poco praticato, almeno come metodologia di lavoro:, ci sono delle piccole iniziative isolate “è stato adottato il bilancio di genere”, ci sono delle buone pratiche, ma non c’è uno sforzo che metta per esempio al centro il tema della violenza contro le donne, l’accesso ai diritti è un pre -requisito fondamentale, non si può dire “signora lei vada a denunciare “ “ma io non ho una casa e non ho un lavoro”… è semplice… Ma se noi siamo un paese che è ai più bassi livelli di occupazione femminile, empowerment cosa vuol dire? Noi abbiamo fiducia nel nuovo piano anti violenza, ma è necessario ricordare che è importante cosa vuol dire denunciare, ossia consentire alle donne che hanno subito violenza di mettersi in una relazione simmetrica, di avere la possibilità di realizzare un percorso di uscita… “Voglio cambiare casa, decido come spendere i miei soldi, cambio città”, senza un forte segno in questa direzione, sarà difficile ottenere una vittoria duratura sulle cause profonde della violenza.